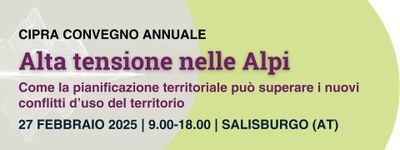Alta tensione nelle Alpi
La transizione energetica e il ripristino della natura si trovano spesso in conflitto. In che modo la pianificazione del territorio alpino può mediare tra le diverse esigenze? Queste e altre domande sono state affrontate in occasione della conferenza annuale della CIPRA, tenutasi a Salisburgo il 27 febbraio 2025.
Dighe, impianti fotovoltaici e parchi eolici: la transizione energetica, insieme alla riduzione dei consumi e alla maggiore efficienza, è una delle risposte più importanti alla crisi climatica. Allo stesso tempo, è necessario procedere al ripristino degli ecosistemi compromessi. Entrambe le esigenze richiedono spazio, elemento che nelle Alpi scarseggia. I conflitti di utilizzo sono quindi inevitabili. “Dietro queste crescenti richieste di utilizzo c’è anche il nostro stile di vita, che richiede sempre più spazio e produzione di energia”, ha dichiarato Uwe Roth, presidente della CIPRA Internazionale. “Occorre pertanto procedere con l’espansione delle energie rinnovabili, concentrandosi tuttavia sulle aree residenziali e non intaccando le ultime aree naturali”. Durante la conferenza, esperte ed esperti hanno fornito spunti di riflessione,mentre nel pomeriggio le/i partecipanti hanno messo alla prova le tesi in lavori di gruppo.
Nuovi ambienti, nuove richieste di utilizzo
Nelle aree lasciate libere dalla fusione dei ghiacciai, solo in Svizzera entro il 2100 si formeranno circa 700 nuovi laghi d’alta quota, con una superficie totale pari a quella di un intero cantone svizzero. Thomas Kissling, Politecnico di Zurigo, conduce una ricerca sul futuro di questi ambienti tra conservazione della natura, turismo ed energia. A suo avviso, la “combinazione di diverse esigenze di utilizzo” potrebbe creare un “nuovo tipo di paesaggio alpino”, come il lago che si sta formando in seguito alla fusione del ghiacciaio del Gorner, vicino a Zermatt. Secondo Kissling, lì si potrebbe produrre elettricità anche senza costruire una diga di grande impatto. Dove sarebbe dunque possibile realizzare impianti di energia rinnovabile compatibili con la biodiversità e il paesaggio? Secondo Lea Reusser, dell’Accademia svizzera delle scienze, si potrebbe adottare una serie di criteri per escludere determinate aree già in fase di pianificazione, ad esempio per tutelare la biodiversità. “Tuttavia, ci sono riserve naturali in cui non è espressamente vietata la costruzione di impianti”, conclude Reusser.
Transizione energetica come processo di apprendimento sociale
La pianificazione della transizione energetica è un processo di apprendimento sociale, afferma Gernot Stöglehner dell’Università di Risorse Naturali e Scienze della Vita di Vienna: “Funziona solo se si definiscono e si perseguono obiettivi di pianificazione vincolanti”. Secondo Stöglehner, è necessario coniugare il livello fattuale con quello dei valori. “La partecipazione è importante, non solo nel processo di pianificazione, ma anche nella fase di attuazione”. Una mancanza di partecipazione può portare a conflitti enormi, come ha riferito Mauro Varotto dell’Università di Padova/I. Da anni la Regione Veneto sta progettando una diga nella Valle del Vanoi, tra l’altro per rifornire d’acqua l’agricoltura della pianura, colpita dalla siccità. Il progetto è stato comunicato troppo tardi, il che ha portato a un irrigidimento dei fronti. “Le montagne non sono solo serbatoi o risorse. Assumono un ruolo importante anche il turismo, la popolazione e l’economia locale”, ha sottolineato Varotto. Questo dovrebbe essere un insegnamento anche per la pianificazione di progetti di questo tipo in futuro”.
La manifestazione è stata organizzata dalla CIPRA Internazionale in collaborazione con CIPRA Austria e CIPRA Germania e con la rete AlpPlan. L’evento rientra nel programma della Presidenza EUSALP del Liechtenstein e dell’Austria. Nell’estate del 2025 è prevista la pubblicazione degli atti del convegno sulla pianificazione del territorio alpino.
Ulteriori informazioni: www.cipra.org/it/chi-siamo/convegni-annuali/convegno-annuale-2025